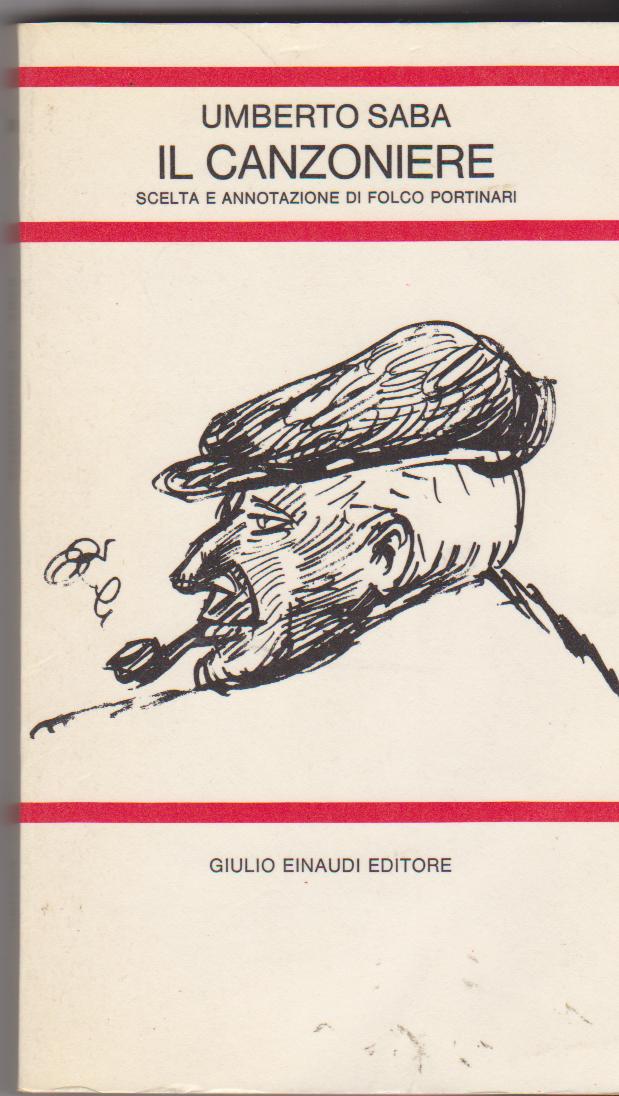 Il canzoniere (1900-1954)
Il canzoniere (1900-1954)
Einaudi
1961
9788806224714

Tre volumi.
Primo: 1900-1920, inaugurato da Poesie dell’adolescenza e giovanili (1900-1907). È una sezione grezza ed embrionale, fracassata da una semplicità e da una linearità a un tempo tediose e puberali; alla deprecabile misura si sposano apprezzabili, ma non nuove, reminiscenze; petrarchesche (il giovane Saba, “incerto del domani”, scrive, in Nella sera della domenica di Pasqua: “Solo e pensoso dalla spiaggia i lenti / passi rivolgo alla casa lontana. / È la sera di Pasqua. Una campana / piange dal borgo sui passati eventi (…)” – sin da questa prima strofa, indubitabilmente, plagiario senza stile) e leopardiane (A mamma: “Ed è un giorno di festa, oggi. La via / nera è tutta di gente, ben che il cielo / sia coperto, ed un vento aspro allo stelo / rubi il giovane fiore, e in onde gonfi / le gialle acque del fiume. / Passeggiano i borghesi lungo il fiume / torbido, con violacee ombre di ponti (…)” – qui opero cesura per non rimarcare la fiacca semplicità e il patetismo dei versi finali; mamma, fiamma e malinconia). È stata un’adolescenza di pochi, ossessivi e selezionati studi: ma ben interiorizzati. Il resto è figlio di quella misura che io chiamo artificio, ed altri intelligenza metrica. Trascurabile: s’apprezza solo quella vaga sfumatura di coraggio che consiste nel non nascondere al lettore quel clima e quelli autori che originarono una produzione così copiosa, e così cerebrale.
Seguono i Versi militari (1908). Chi ama il giovane, disperato e crudo Ungaretti e il malinconico Apollinaire si rassereni: qui siamo ai prodromi del male, si scrive senza vivere la morte. Si va dalla porcheria di maniera (Durante una marcia: “Il cielo, senza mai piovere, tuona”: sette tempi per dire d’avere equilibrio, e d’essere soldato nostalgico; di donna) alla purtroppo irrisolta omosessualità, cantata in versi che vanno a scolpire “equine gambe, cosce di possente / mulo io scopro; mentre in lei vedere / so uno svelto, un sagace levriere” in A un ufficiale. E dire che non c’è traccia di sentimento diverso dalla presunzione, in questo padre di versi normali e blandi: “E vedono il terreno oggi i miei occhi / come artista non mai, credo, lo scorse”. Ordine sparso è un titolo proditorio. Questo è ordine, e del più bolso. Godibile, altrove, questo “zaino che sega le ascelle” (La ginnastica del fucile) e la visione di volti “ebeti o cagnazzi”, subito rovinata dalla rima “pazzi” (Il capitano); un generico senso di stanchezza e di estraneità, sublimato dalle reminiscenze letterarie – ancora una volta, accessibili: Faust, ad esempio, in Dopo il silenzio. L’acme di questa sezione è in quest’ultima strofa poverella: dove per “poverella”, ci s’intenda, non si vuole associare la grazia minima ed essenziale francescana; ma la miseria vera di chi scriveva in versi non dovendo, e non aveva niente di nuovo o di giusto da cantare, se non questo: “E seggo, e sulla sabbia umida e netta / un nome da infiniti anni obliato / scrive la punta della baionetta” (Di ronda alla spiaggia). Non mi curo del richiamo religioso, sono un goy: fossi ebreo, penserei a un’astuzia, e all’ira del non pronunciabile “colui che è” per la mercificazione (normalizzazione) stolida, e in versi.
Quindi Casa e campagna (1909-1910). Pascoliano incipit è L’arboscello. Terrificante e animalesca A mia moglie, destinata all’adozione incolore nelle antologie mute della scuola dell’obbligo. Splendido invece il guanciale di pietra dell’insonne, nell’altrimenti fiacca L’insonnia in una notte d’estate – prosaica sin dal titolo. Altra sezione è Intermezzo a Lina: io scaglierei via il libro dopo due versi: “O di tutte le donne la più pia, / rosa d’ogni bontà”: per non tacere di questo nauseante “e tutta hai rivestita / di fascini la tua malinconia, / e di civetteria la santità”: nasce straziante voglia di violare questa finzione di carne e di amore, e di far del bene rivelando menzogna. Prendendo il corpo di quella che qualcuno non aveva che comprato, senza avere. L’amata non sa cantarla altrimenti che per allegoria di bestie, e belati di santità: tempio di carne mai violata, e sconosciuta: deprecabile.
Ecco Trieste e una donna (1910-1912);
Presentiamo l’immortalità di Saba, nel canto della più splendida tra le città italiane distanti da Roma; all’epoca non frontiera, ma ibrido cosciente di popoli, culture e letterature; nell’architettura, estatica e immobile come oggi appare, ma allora viva. Trieste:
Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia.
(…)
La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva
Petrarchesca clausola a parte, ecco testimonianza di quanto e come sia possibile interiorizzare scorci e frammenti e poesia d’una città: Saba capisce Trieste chiamandola maschio, e maschi doveva cantare, non pecorelle e uccellini e capre di lino spacciate per amori: non capisce le donne, è uomo di uomini – peccato per questa sua frustrata natura, che s’è espressa con scontrosa grazia qui e altrove. Ma di rado. Non a caso: “Trieste (…) tiene d’una maschia adolescenza / che di tra il mare e i duri colli senza / forma e misura crebbe” (Verso Casa). Quanto ci ha negato questa rimozione di verità?
E la donna è la bugiarda: natürlich: cosa doveva o poteva dirti, Umberto, di dicibile? Credi solo alle sue bugie: appunto; sii bravo, e risparmiati i colloqui con Weiss. L’amore di Saba, e i suoi talenti erotici, splendono e scintillano in versi come quelli dedicati a Il giovanetto. Qui è vero e dolce e canta: “Tu stai sul prato come un dio in esiglio / sta sulla terra. E, chi ti ammiri, l’occhi / non abbassi, lo guardi con fierezza, / come un nemico, in volto; / mentre al compagno nella finta guerra / parli sommesso e ridere t’ascolto”.
Ecco qua: appunto, distilla malinconia nel cuore. Questo è amore.
Il cantuccio di Saba l’abbiamo visitato – è ancora immutato, a ben guardare; e ripete questi versi, sorridendo lascivo e incauto. Per ritrovarlo ho atteso cento anni, poco meno: Karlsen in Trieste è poco o nulla: ecco qui:
E te la vederà silente, dormenzada,
scipìda. Rincoionida dale parole scrite,
dale parole parlade ch’essa la produci
e noi le produciamo, e mi le produco
per non dir quela, che Trieste
no xe poco, no xe, nula.
Discreta lirica ancora Tre vie, che andrebbe mutuata in canto e donata al viandante che si lascia rivelare la città fedele solo all’Austria; correggendo rime stupide e odiose, che deturpano la purezza e la felicità dei versi.
Tra le peggiori poesie della storia della letteratura italiana è Il poeta: è un inno a farsi amatore e dilettante astuto, a schermarsi con la metrica per non ammettere di non aver mai capito cosa fosse Dioniso, e cosa il Verbo, e quale sia l’essenza della poesia. Saba non ne sa niente: sa di Trieste, e degli uomini – questo sì, certo: sì. Peccato ne parli, sinceramente, troppo di rado.
Femminilità disgustata, ad esempio, in un’immagine come questa: “braccia come serpi” che la moglie – sempre lei – getta al collo del marito poco fantasioso e triste, al ritorno a casa: non è Medusa, è biscia. Terribile. Immancabilmente, il gusto per il brutto sprofonda nella sezione Nuovi versi alla Lina: è uno strazio, ed è tutto così chiaro. Meglio non insistere: “Una donna, una ben piccola cosa, una cosa – Dio mio! – tanto meschina (…) Una donna, un nonnulla. E i giorni miei / sono tristi, una donna ne fa strazio, / piccola, che una casa nello spazio, / un piroscafo è tanto più di lei”: accidenti, povera Lina. Archetipo nuovo, e tanto infausto. Altrove: “La fatica ch’io duro è vana cosa, / che più ritorni quanto più ti scaccio”: e Lina è impazzita, racconta la biografia. Eppure era stata chiara: Umberto, “Questo tu devi: amarmi”.
Nuova sezione è La serena disperazione (1913-1915).
Termina la giovinezza, l’artista ha il cuore vuoto. Il mondo è cimitero: il poeta non più dorme, ripete per consolarsi il segreto del Sileno (Il patriarca). Cerca compagnia nelle osterie, vagheggia i bordelli (ma non va, parrebbe), guarda e ascolta ma non interagisce quando trova l’anima d’esser popolano. Quei caffè di plebe – come li chiama – sembrano più desiderati tanto più che ne offende la fauna. Quindi, Poesie scritte durante la guerra: vale quanto detto per Versi militari – Saba la guerra non sa proprio cosa sia. È un voyeur dei soldati, e dei morti, e delle rovine. Poco altro. Mediocre versificatore di vite non sue; saccheggia quel che non conosce e non capisce, e male.
Subentrano le Tre poesie fuori luogo: minaccia d’un suicidio che non avviene, lamento di giovinezza (quale?) perduta, speranza che il canto sia guaritore (come, se non è che verso?). Cose leggere e vaganti (1920) ospita il lezioso e mite Ritratto della mia bambina, zavorrato dall’iconografia classica della nascita di Venere – onestamente, grottesco – e come incompiuto e inespresso. Soffocante Sopra un ritratto di me bambino, e ancora una volta specchio d’un poeta che altro non era che specchio: guardava guardarsi guardato. Sbadigliava chi stava sbirciando; Umberto era laido, e non poco.
La prosa e il diarismo da cameretta si impadroniscono sempre più del comprensibilmente estraneo alla luce letteraria: la lettura rallenta e inciampa, per i goffi o nulli momenti di vitalità d’una scrittura nata morta, e pallosa.
Strapiombo è l’orrida Mezzogiorno d’inverno. Perché non bruciare quel che s’è scritto, se tanto semplicemente appare storpio e fiacco? Mistero.
Giusto commiato: “Voi lo sapete, amici, ed io lo so. / Anche i versi somigliano alle bolle / di sapone; una sale e un’altra no”. Eh, già. Già. Brucia queste cazzate, bruciale, Saba!, nella prossima reincarnazione: sono intossicanti, e squalificanti. Questi versi hanno figliato imitatori – mio dio – e non si stancheranno di abbrutirci. Umberto, altro che Paolina: tu canti a Vanvera. Come i vecchi noiosi, e senza storie. Superbi d’aver pensato che al verbo succede un complemento oggetto. Sei colpo di tosse d’un polmone stanco.
L’amorosa spina (1920) – patetiche e già lette liriche sentimentali, rivolte, e non stupisce, a donne. Una è “uccella sul più alto ramo”, o “egoista e civettuola”, una si busca un bacio, e poi lui la chiama brutta – senza pensarlo, certo. Carta da parati, se va bene – ma ben riversa, e macchiata di grappa.
***
Volume Secondo: 1921-1932. S’apre con la sezione Preludio e canzonette: cosette civettuole, per dirla con parole comuni nel lessico del poeta, nonnulla e malinconia – di maniera, sia chiaro. Siamo a un livello tanto elementare che adirarsi per il tempo perduto a leggere è vano: “La vita è così amara, / il vino è così dolce; / perché dunque non bere?” (Il vino); non s’individuano immagini che non siano tiepide, o fredde, o ammorbate da una linearità boriosa. Ma ecco uno squarcio di verità: “Io non so amare, / io non so fare / bene che questa cosa, / cui dava a me la vita dolorosa / unico scampo”. Ovviamente allude ai suoi talenti di poeta: transeat, ha scritto Trieste. Lei sola basta. Triste quel poeta che non sa amare, e scrive del non è spacciandolo per reale; nemmeno divertono le bugie, quando sono così piane.
Altra sezione ha il curioso titolo Autobiografia – quasi fossimo stati a leggere un libro di visioni di Blake, sino ad ora. Tornano richiami alla giovinezza (quale?) infelice, ammissioni d’un orgoglio letterario forse immotivato, puntuali riflessioni sulla commistione di razze che ogni triestino, tuttavia, non trova nuove; ma apprezzabili e famigliari, certo. S’intravede un amico cui si scrivevano lunghe lettere, “come a una sposa”; egli era “bello e lieto come un dio”: e quindi? Niente: Saba s’è scelto una prigione buffa, di donne-uccello e di infelicità. E non sembra essersi illuso troppo.
Piacevole solo, altrove, la digressione sulla bottega d’antiquario – la viva appartenenza è più che un topos; vorrebbe morire da poeta sulle sue carte, spezzato “dal chiuso fervore”, chiudendo quegli occhi che “han veduto” (sì, e basta) tanto.
Segue I prigioni (1924): parlarne è sciocco, è solo architettata sezione di vizi e attitudini – e non ha ispirazione, né grazia. Si cantano l’empio, il violento, l’accidioso (oh morale del bigotto…), l’appassionato (!), l’amante (“lussurioso”), l’eroe (il lettore ride di questo Oreste, matricida: sì, mentale), della malinconia compagna, del beato (forse – si consola: già immortale. Sbadiglio).
Qui rischiamo grosso: Fanciulle (1925). È una serie di donne senza volto, astratte – narrate, per un dettaglio; capelli, fronte, mammelle. O per uno sguardo. Non sempre belle, tendenzialmente bugiarde. Sono versi d’un onanista: non infiammano, non hanno erotismo; questa è acqua calda, o semolino. Brodaglia: rancio d’erudito, laido e manolesta.
L’irritazione è accresciuta da Cuor morituro (1925-1930). Sonetti languidi e immaginine pascoliane, argomenti e temi ormai ripetuti e reiterati a oltranza, fino alla nausea; nessuna variazione, nessuna sperimentazione; prosa impilata in versi, miseria d’un ego che non vive e pensa – e nel pensiero di vivere una vita semplice e piatta s’emoziona, e la carne sembra emozione e delirio –, vaga moralità e allucinata repressione, dubbi doppi sensi (Il fanciullo e la verga), che figliano appunto riso di pensionato, e tanta noia. È l’eco – larga parte di questo libro – di una o due buone intenzioni: infine logorroiche, annacquate e sciatte.
Nessuna sorpresa più attende il lettore. C’è qualche abbozzato canto a due voci, elementarità spacciata per poesia, enfasi sentimentale d’amori tanto esigui e tenui da sembrare falsi; precipizi di solitudine, di malessere, di malinconia; insonnia, ansia di origine (l’errante cerca sorgente, sempre: è sedentario perché inconsciamente ha capito) e vaghi tormenti d’un’infanzia torbida e depressa. Stesso discorso varrà per Volume Terzo (1933-1947): al di là dell’attesa rinuncia alla rima (l’uccellino ha rotto la gabbia, prima di svolazzare sghembo), delle apprezzabili poesie dedicate al gioco del calcio, l’autore che chiede di rinunciare all’alloro e di precipitare nell’oblio s’impaluda tra un’ennesima ripetizione del mito di Odisseo e vaga narrazione di scorci triestini; non c’è rimpianto che non nasconda autoincensamento, non c’è mai la sensazione di sfogliare il libro d’un umile; Saba sembra innamorato del puzzo di chiuso della sua vita, della sua autoreferenzialità, e l’alterità non è che una scusa per dire: una volta ancora, come dagli anni della giovinezza (quale?): io.
Questo io, tracimante spocchia e arroganza più ancora, perché velato da una patetica modestia di comodo e d’occasione, ha osato rubare a Petrarca nome del libro e prima architettura: contemporaneo di Ungaretti, di Campana o di Gozzano, sembra non essersi accorto d’esser vissuto. Una bottega d’antiquario, tra amorazzi scialbi e donne che non potevano essere uomini: pioggia di versi senza mai adeguata legione di lettori, e la ragione non è difficile da intendere.
Qualche lirica sublime non giustifica una schiera di borborigmi in versi, e di depredate immagini, e di rannicchiati e trasandati versi. Libro che ha una corteccia di quindici pagine, e una palude di trecento poesie. Nel fango si nascondono diamanti; quel fango è orrido, e dà nausea. Come la bugia peggiore – quella capita e in fondo rivelata, per smozzicati sussurri; ma mai ammessa. Sulla pelle dei contemporanei, e dei lettori, s’inchioda la carcassa d’un morto. È pesante, troppo, e strascinandola via mi sembra zagagliare: poesia, poesia.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Umberto Saba (Trieste, Austria, 1883 – Gorizia, 1957), libraio e poeta triestino. In giovinezza, declamò versi nei caffè fiorentini con lo pseudonimo di Umberto da Montereale. Non piacque a Papini. Papini va rivalutato.
Umberto Saba, “Il canzoniere (1900-1954)”, Einaudi, Torino, 1961. Introduzione di Nunzia Palmieri.
Approfondimento in rete: Letteratura.it / Italia Libri / Antenati.
Gianfranco Franchi, Giugno 2005.
Prima pubblicazione: Lankelot, poi Absolute Poetry.
“Il canzoniere” è davvero un classico? Come invecchia la lezione e la scrittura di Saba?
