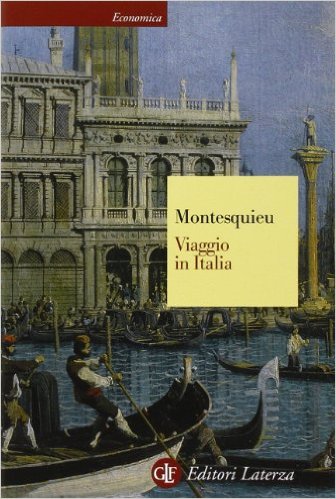 Viaggio in Italia
Viaggio in Italia
Laterza
1995
9788842047131

“Sulle strade d'Italia non puoi volgere gli occhi senza vedere un monaco, come per le vie della città senza vedere un prete. Tutte le carrozze, tutte le imbarcazioni sono piene di monaci; è gente che odia a morte i conventi, ed è sempre in viaggio. L'Italia è il paradiso dei monaci, e non c'è un ordine, la cui disciplina non sia rilassati. Le faccende che tutti i monaci del mondo hanno da sbrigare a Roma ne popolano le strade” (Montesquieu, “Viaggio in Italia”, p. 114).
Quando Montesquieu visita l'Italia tra agosto 1728 e luglio 1729 e racconta la condizione degli Stati italiani del Settecento, non abbiamo una Capitale: non siamo una nazione. Un uomo che credeva che Parigi facesse i francesi non poteva che trovarsi disorientato: “Le repubbliche italiane non sono che miserabili aristocrazie, che si reggono solo per la pietà che si ha per loro, e in cui i nobili, senza alcun senso di grandezza e di gloria, ambiscono soltanto a conservare il loro ozio e i loro privilegi” (p. 204). Oltretutto, incoscienti: “non v'è nulla di peggio in uno Stato che quella condizione e quella certa disperazione che impediscono di considerare la propria situazione” scriverà, ad esempio, parlando di Venezia.
Amava le contraddizioni dell'Italia, a dispetto del dolore di fronte alla miseria e alla grettezza; e in Italia, lui illuminista, riconobbe forse un miracolo (coagulazione del sangue di San Gennaro: cfr. p. 220 e ss.). Il suo “Viaggio in Italia” costituisce (fonte: Nota al Testo di Colesanti) i tre quinti di tutte le note di viaggio dell'autore; siamo privi sia di edizione critica che di edizione “passabile”; il libro è composto di note e appunti, nervosi e sconnessi, assemblati senza un criterio definitivo o univoco. Colesanti ha collazionato manoscritti e testi a stampa, confermando che a trascrivere i testi, con l'eccezione di un foglio autografo, sono stati i segretari dell'intellettuale francese. Non esclude che siano stati rimaneggiati dall'autore in previsione di un'opera compiuta e organica. Ciò detto, entriamo nel cuore del libro. Premetto che trascurerò tutte le osservazioni – e sono molte – riferite alle imposte, alla condizione economica degli Stati, ai canali, alla natura delle fortificazioni; che non accennerò nemmeno agli appunti riferiti alle opere d'arte e ai palazzi, perché di notule si tratta e non di analisi, con rare eccezioni; idem, trascurerò i pettegolezzi sulle oligarchie e sui rapporti tra la Francia e i vari Stati, preferendo puntare sugli aspetti antropologici o di folklore che possano rivestire interesse per il lettore contemporaneo.
Come osserva le città, il nostro filosofo? Spiega Macchia: “Montesquieu osserva prima la città dall'alto. Quando giunge in una città, si situa sul campanile più alto, o sulla più alta torre, per vedere le tout ensemble, prima di distinguerne le parti. Quando la abbandona, ritorna sullo stesso campanile, per ben fissare le proprie idee” (p. XV). E precipitando in città, ascolta e osserva con viva curiosità le voci e i costumi dei cittadini. Sembra desideroso di catalogarci, come fosse un etologo o un entomologo, puntando soprattutto sui punti deboli e sulle contraddizioni dei nostri popoli. È come Darwin alle Galapagos.
VENEZIA. Nella prefazione, Macchia scrive che la permanenza, durata un mese, aveva lasciato a Montesquieu “un senso di sorda irritazione. Era la città degli occhi, non della mente e dell'anima: ombra vaga di una grande civiltà in decomposizione. Il personaggio che animava la vita cittadina era la prostituta, l'esecrabile prostituta veneziana su cui il pensiero di Montesquieu ritorna, anche quando ne è lontano, come su un'idea fissa” (p. IX). Nelle caustiche pagine dedicate a Venezia, Montesquieu osserva che mai come in Italia ha incontrato tanti devoti, e così poca devozione: “I Veneziani e le Veneziane sono di una devozione che incanta: un uomo può anche mantenere una puttana, ma non perderà mai la messa (...) e non crediate che le cortigiane vadano a guastare i loro affari in chiesa” (p. 5). Elogia i veneziani per l'assenza di risse e schiamazzi in città, per la bonomia e per la tolleranza (nei confronti dei creditori), ammonendoli: paura e avarizia sono i loro punti deboli (p. 16), assieme all'eccessivo lassismo (p. 18).
Osserva che la notevole riduzione del numero di puttane in città è dovuta a una crisi del turismo (35mila stranieri contro 150: il Carnevale ha meno fortuna): al contempo, dà per scontato che l'economia di Venezia si fondi in buona parte sulla loro attività, pensando a quanti denari facciano spendere ai giovani. Seguono puntuali esami sulla compravendita dei titoli nobiliari, sul valore dell'oro e dell'argento, sulle merci nei magazzini, sul contrabbando, sulla provenienza dei Leoni e via discorrendo: niente che abbia interesse letterario, materia per curiosi o specialisti.
Le maschere del Carnevale? Non sono un travestimento: i veneziani “si cambiano d'abito raramente, e tutti si conoscono. Al nunzio del Papa, che era in maschera, un tale chiese in ginocchio la benedizione. Un tempo, quando le Veneziane erano strettamente sorvegliate, mascherarsi era per loro un divertimento, perché le liberava da ogni soggezione. Ancora oggi possono andare a far compere da un mercante o passeggiare per piazza San Marco solo durante il carnevale; ma andare a farsi fottere nelle loro gondole, dove vanno con chi vogliono, e dove vogliono, sempre” (p. 14). E i conventi, finalmente, si stanno svuotando, aggiunge: la sregolatezza delle donne del mondo ha messo rigore in quelle donne che vi avevano rinunciato.
Qualche curiosità, prima di passare oltre: gioverà ai lagunari sapere che M. credeva che la città non avesse porti rivali (Trieste e Fiume, scrive, “non valgono nulla”); che si lamentava che nessuno o pochi passeggiassero nei giardini, sulle isole; infine, asseriva che democraticamente “A Venezia non vi si chiede né carrozza, né domestici, né abiti: la biancheria pulita vi pone sullo stesso piano di tutti”.
DA PADOVA A VERONA. La Padova raccontata da Montesquieu è una città quasi deserta, passata da 3000 a 300 studenti; la concorrenza delle Università italiane, tedesche e della città di Venezia, asserisce, ha “segnato la decadenza” di Bologna e Padova. Gli stranieri, in primis gli inglesi, hanno “portato via tutto da Padova, come nel resto dell'Italia”: senza le chiese, scrive, non ci sarebbero più quadri (p. 55). Insomma: ci si vendeva anche le mamme, potendo. A Roma, leggeremo più avanti, servirebbe in tempi brevi una legge per vendere le case assieme alle statue: altrimenti la città sarà spogliata (p. 155).
Verona è una città piegata dalla miseria. “I Veronesi sono poveri. Non potete vedere un uomo senza che vi chieda denaro: un calzolaio, dopo avermi venduto delle scarpe, mi ha chiesto l'elemosina; uno che vi ha venduto un libro vi chiede la bona man; uno che vi indica una strada o chi vi dà una notizia, vi chiede la ricompensa (...): non è per bere, è per vivere. (...) La furberia, compagna della miseria, regna” (pp. 61-62). Come se non bastasse, in città la violenza è famigliare a tutti (“le bastonate si danno qui familiarmente, come scappellate”).
MILANO. Montesquieu, accolto dal fiore della nobiltà meneghina, si sente subito a casa: Macchia sostiene che “sembra che si spogli della veste di scienziato quasi quarantenne, di accademico di Francia, di ex presidente del Parlamento di Bordeaux, per essere soltanto un aristocratico” (p. X). Questo approccio, purtroppo, inficia le sue malevole osservazioni sugli abitanti della città e del contado. Tra i rilievi interessanti: la Lombardia era la regione più popolosa d'Italia (nel Milanese, all'epoca, circa 800mila abitanti).
TORINO: bontà sua, “Torino è una città ridente”, dichiara l'autore: “ridente” e piccola, nonostante i recenti (per l'epoca) ampliamenti e a dispetto della povertà dei gentiluomini locali. Fortunatamente, più avanti si ravvede: “abbastanza noiosa” (p. 94). I Piemontesi, leggiamo, sposano raramente qualcuno di rango inferiore (p. 83); a Torino non si mangia, perché “un pranzo offerto a qualche straniero è una grande novità per la città, e se ne discute molto”. È molto colpito da come “i muri parlino” in terra sabauda: “si sanno le più piccole cose delle famiglie, fino ai matrimoni dei più piccoli borghesi, e ci si interessa di queste cose”.
SARDEGNA: Montesquieu è corrosivo: i Sardi “non hanno acqua, né aria”: l'acqua è quasi tutta salmastra o salata. E non hanno nemmeno burro: quello che hanno è come vecchio grasso. Non piantano alberi e non falciano l'erba, e come se non bastasse per via della malaria si può uscire dalle città soltanto per cinque mesi l'anno (ne riparla ancora a p. 250). I sardi non hanno più alberi da frutta, aggiunge. E il loro grano è cattivo, si guasta per strada. Ma poi si riprende: i Sardi sono intelligenti (p. 84). Infine, annota che preferisce Sassari a Cagliari, senza darne ragione.
GENOVA: al di là degli apprezzamenti sulla bellezza della città, il filosofo registra la povertà della Repubblica, l'indole poco coraggiosa ma molto orgogliosa dei suoi cittadini e l'altezzosità delle cittadine. Aggiunge che si tratta di un popolo niente affatto socievole, forse per via dell'estrema avarizia: “Non c'è niente di più bugiardo dei loro palazzi: di fuori, una casa superba, e dentro una vecchia serva che fila (...). Invitare qualcuno a pranzo a Genova è una cosa inaudita” (p. 108). Più avanti: “la timidezza si può vincere, l'avarizia no” (p. 152). Infine, aggiunge: “I Genovesi non si raffinano in nessun modo: sono pietre massicce che non si lasciano tagliare. Quelli che sono stati inviati nelle corti straniere, ne son tornati Genovesi come prima” (p. 109). Singolare primato ligure: “le terre più cattive del mondo”.
LA SPEZIA: Il porto – tutto il golfo – è una delle cose più stupende che ci siano in Italia.
PISA: poco popolata, a dispetto d'un tempo (ma questa è l'osservazione principe riferita a quasi tutte le città, con l'eccezione di Livorno; troppo grandi per i quattro gatti superstiti, ogni cosa sembra memoria d'un passato diverso): ma “Livorno le fornisce denaro, e i Lucchesi, gente” (p. 137).
FIRENZE: qui si “vive con molta economia. Gli uomini vanno a piedi. La sera, si fanno lume con una piccola lanterna. Le donne vanno in grandi carrozze. Nelle case, quando non si gioca, l'illuminazione è data da una lampada; quando c'è poca gente, una fiamma; quando la gente entra, accendono tre fiamme: perché la lampada ha tre bracci e poggia su una specie di candeliere. Per il resto, la nobiltà fiorentina è affabile, e la razza è abbastanza bella. Le donne non sanno cosa vuol dire belletto. Nessun caminetto e, nel cuore dell'inverno, niente riscaldamento. Dicono che il fuoco è malsano, ma potrebbe essere per ragioni di economia” (p. 124). Montesquieu insiste: non esiste città più spartana, basta una lanterna per la notte e un ombrello per la pioggia. Le donne sembrano particolarmente seducenti (“credo che la vita regolata, un regime rigoroso, la particolare qualità dell'aria le mantengano così”, p. 141). 80mila anime, 800 monaci, 800 suore, senza contare i preti (Siena, all'epoca, s'attestava attorno ai 75mila).
LUCCA: “Hanno tre principi: niente Inquisizione, niente Gesuiti, niente Ebrei” (p. 139). Ebrei piuttosto popolari a Livorno, invece: 5000 su 35mila abitanti, dice qualcuno. “Rinchiudere gli ebrei in un quartiere – scriverà più avanti, tra i suoi appunti riferiti a Roma – senza che abbiano possibilità di espandersi, e dove vivono alla rinfusa, è un provvedimento barbaro, che inoltre può causare anche malattie contagiose” (p. 255).
ROMA: “Un Paese migliore, ma più miserabile”: ci illude l'incipit. Forse perché “Le pietre parlano”: non i muri, come a Torino. Ma ecco che “persone vestite meglio di me mi chiedono l'elemosina”, osserva Montesquieu. Accattoni e furfanti. Oppure, e al limite, “gente pretenziosa”, dirà più avanti. Nello Stato Pontificio non c'è né commercio, né industria; le terre sembrano molto mal tenute. La malaria colpisce, secondo un Cardinale, perché “le acque non scorrono più tanto bene; ci sono fossati sulla riva del mare, che d'estate si asciugano producendo insetti ed esalazioni cattive; miniere di allume emanano esalazioni” (p. 149). Intanto, i privilegi degli ecclesiastici sono rigorosamente mantenuti dalla “Congregazione dell'Immunità”, istituita già nel lontano 1626. Gli assassinii sono più frequenti nello Stato Pontificio che a Roma. Il Papa Benedetto XIII è “molto odiato” dal popolo romano, perché “fa morire di fame”, preferendo investire denari per Napoli e per lo Stato della Chiesa rispetto alla Città Eterna.
Morale della favola? “Una pubblica simonia regna oggi a Roma. Non si è mai visto, nel governo della Chiesa, regnare il delitto così apertamente. Uomini vili sono preposti da ogni parte alle cariche. Ed il popolo da parte sua non si cura affatto di ciò che può accadere. Da come vanno le cose, è impossibile che sia eletto papa un uomo di merito: non lo vogliono” (p. 153).
Non basta? Certo che no. Delenda Roma(ni). A dare il tono non sono le donne, ma i preti. E... “La maestà del popolo romano, di cui parla Tito Livio, è molto degradata. Questo popolo è oggi diviso in due classi: le puttane e i servi o staffieri. Coloro che sono di condizione superiore, eccettuati una cinquantina di baroni o principi, che non contano niente, è gente che non fa che passare, e strada facendo fa la sua fortuna, ed entra nel governo, e ne occupa i primi posti. Ognuno sta lì come in una locanda, che si fa aggiustare per il tempo che ci deve rimanere. Oggi il popolo romano est gens aeterna, in qua nemo nascitur: tranne qualche bastardo. L'S.P.Q.R. È stato interpretato: Sanno putare queste romane”. Per “putare” si intende “fare le puttane”. Montesquieu scriveva quella frase in italiano. Sublime, no?
Tranne qualche bastardo, ci diceva. Del resto, “Il marchese Bolognetti mi ha detto che Roma ha 144mila anime; che ne aveva solo 120mila nel 1675; che è difficile trovare, su 100 persone, 10 che abbiano madre e padre romani e che siano nati a Roma” (p. 170). Una frase che sentiamo ripetere anche oggi: curioso. Non è finita: è “comunissimo” che da noi ci si venda la moglie in cambio di denaro o protezione; altrimenti, post matrimonio la donna può essere “buona sgualdrina” (p. 190).
Quanto agli abitanti, ecco altri dati certi: “Roma aveva 80mila abitanti al tempo di Leone X; 110mila al tempo di Clemente X. Dopo il suo pontificato, è arrivata a 138mila” (p. 249).
Curiosità sparse: Montefiascone era già famosa per i fini nel 1729; Roma, a dispetto degli abitanti, rimane “la più bella città del mondo”: perché se le arti si perdessero, si ritroverebbero qui da noi, nell'Eterna (p. 211).
Già si parlava di bonifica delle Paludi Pontine: “poteva essere prosciugata facilmente, e con una spesa di 20mila scudi romani si sarebbe costituito un capitale di 5 o 600mila scudi” (p. 229). Civitavecchia era in rampa di lancio: “Il Cardinale Imperiali mi ha detto che è impossibile che Civitavecchia non si sviluppi, perché c'è la fortezza, ci sono le galere, e vi entra più denaro di quanto ne esca” (p. 246).
Infine... chi conosceva la storia della Pineta Sacchetti? “Sono stato a vedere il Pigneto Sacchetti, una casa abbandonata perché una volta tutti quelli che vi abitavano morirono a causa dell'aria cattiva, che proviene sia da una valle sottostante, sia da un bagno che stava sotto la casa. Si trova a un miglio da Roma” (p. 234).
FONDI: Centoventi anni dopo Montesquieu, Dickens avrebbe composto note agghiaccianti e difficili da dimenticare su questa cittadina (si veda “Impressioni italiane”). Il francese, invece, a suo tempo non aveva notato tanta miseria e disperazione: “Il Papa era passato per Fondi dieci o dodici giorni prima di me, con un equipaggio molto modesto, veramente da non dirsi. Era vestito interamente da monaco. (…) A Fondi c’è un piccolo castello quadrangolare, merlato, come ne facevano anticamente. Barbarossa lo espugnò e ne fece schiavi tutti gli abitanti” (p. 209)
NAPOLI: Anticipando Dickens – che fosse la stanchezza del viaggio? - il barone Montesquieu è decisamente negativo: “Mi sembra che chi cerca le opere d'arte non debba lasciare Roma. A Napoli mi pare che sia più facile guastarsi il gusto che formarselo” (p. 211). Ancora: Napoli si può vedere in due minuti, mentre non bastano sei mesi per vedere Roma (p. 230).
Il filosofo insiste: i Napoletani vivono di minestra e di elemosina, tra miseria e pigrizia (p. 215). Nessuno sa di preciso quanti siano; le stime variano tra 300 e 500mila. 50 o 60mila tra loro sono “Lazzari”: vivono di ortaggi, vestiti solo d'un paio di brache, facili alla rivolta: sono gli uomini “più miserabili della Terra” (p. 222). I partenopei sono gente credulona, avida e e superstiziosa: la loro plebe è più plebe delle altre (p. 223).
Curiosità: si parla di un “buon sacerdote”, l'abate Ripa, che aveva invitato giovani cinesi a Napoli per istruirli e inviarli in patria a predicare. Erano quattro, ma ne sarebbero seguiti degli altri, nei disegni del Clero.
ROVERETO: Al termine del viaggio, il barone vuole parlare di una delle nostre frontiere. Rovereto, inizia, è una città che lavora. Sin qua tutto bene. “Queste popolazioni ai confini tra la Germania e l'Italia non sono controllate da nessuno; sono, in certo senso, libere, e di conseguenza insolenti: non c'è nulla di peggio della plebaglia abbandonata a sé stessa. Si aggiunga che i furfanti fissano più volentieri la residenza ai confini tra due Stati” (p. 308).
La gente del popolo italiano, in generale, si fida poco: “ognuno non pensa che a ingannare gli altri, a mentire, a negare i fatti. Nessuno si fida dell'altro” (p. 308). Terminato questo grand tour, rimangono addosso sentimenti e sensazioni contrastanti; da un lato, puerilmente, ci si sente onorati per aver ospitato un cittadino di tanto grande intelligenza e considerazione nella storia della civiltà occidentale: si pensa alle targhe affisse nelle città, “qui dormì...”, e si sorride al pensiero della bellezza e della popolarità del Belpaese.
D'altra parte, analizzando quanto scrive dei nostri popoli, cadono le braccia e si vellica la depressione. Lo scenario classico di questo libro è la descrizione della povertà, della miseria, del furto e della prostituzione; dell'accattonaggio e delle città grandi ma deserte. Il Settecento italiano, con l'eccezione di Milano e dei lavori di ristrutturazione nell'Anfiteatro di Verona, ne viene fuori con le ossa mostruosamente rotte. Siamo un popolo di banditi, mignotte e poveracci, massacrato dalle imposte oppure ridotto in condizioni di vita ridicole; viviamo in terre aride e in città sporche, e le opere d'arte nascoste nelle Chiese per non essere vendute allo straniero di turno raccontano d'un passato che più non ci appartiene. L'approccio “scientifico” di Montesquieu mostra tutti i limiti di una nazione frantumata in staterelli e in particolarismi non comprensibili, di cittadini ignoranti e vessati, di cittadelle in rovina.
Da leggere – niente affatto per ragioni letterarie: si tratta, valga la pena ripeterlo, di appunti caotici e farraginosi, immediati e non approfonditi, tendenti alla superficie profonda o alla superficie e stop, per quanto riguarda gli aspetti antropologici; è un documento storico, utile per capire come venivamo letti e interpretati dagli intellettuali stranieri, e come siamo stati raccontati nelle loro patrie. Come una massa di pezzenti, quando va bene; come una massa di accattoni e di prostitute e di ladruncoli, quando va male.
L'italiano dipinto da Montesquieu è un subumano, odioso e respingente, patetico e animalesco. Le eccezioni fanno parte dell'aristocrazia milanese. Da brividi.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu (Bordeaux, 1689 – Parigi, 1755), illuminista, teorico del liberalismo settecentesco; filosofo e giurista.
Montesquieu, “Viaggio in Italia”, Laterza, Roma-Bari 2008. A cura di Giovanni Macchia e Massimo Colesanti. Prefazione di Macchia, Nota al testo di Colesanti.
Prima edizione: “Voyages”, 1894-96, 2 voll.
Gianfranco Franchi, febbraio 2009.
Prima pubblicazione: Lankelot.
