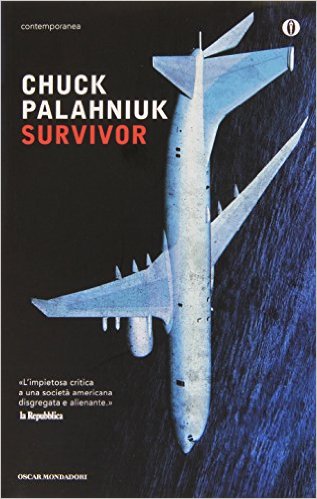 Survivor
Survivor
Mondadori
2015
9788804654452

Palahniuk è l'espressione del malessere individuale in una società che tende a commercializzare e fagocitare tutto: è la sintesi degli impulsi distruttivi e autodistruttivi dell'individuo, il cantore apocalittico e cupo del male di vivere in America – in Occidente? Non direi, e in ogni caso non sempre vale – nei giorni nostri. È un autore che non vuole regalare particolari colpi di scena: spesso i suoi romanzi cominciano dalla fine, e si sviluppano in analessi, per concentrare il lettore sulle dinamiche psichiche e sulle interazioni tra i personaggi, non sugli eventi e sugli snodi narrativi. I suoi personaggi sembrano incompresi e isolati; quando l'incomprensione e l'isolamento terminano, sembra che nemmeno questo basti. È come un bambino che pretende affetto e quando ne riceve non gli basta; è uno che sembra veicolare una smania di distruzione e autodistruzione senza precedenti. Altro che nichilismo, siamo ben al di là di quella soglia. Palahniuk è il distruttivismo. Uno che se potesse scrivere l'Apocalisse sarebbe grato a Dio per l'ispirazione e per l'autorizzazione. E andrebbe a migliorare il canovaccio con spunti originali. Per pura dedizione.
“Survivor” (1999) è stato il suo terzo romanzo; il secondo, cronologicamente, a vedere la luce (la prima creazione, “Invisible Monsters”, apparirà subito dopo). La critica italiana (“Repubblica”) ha voluto considerarla una “impietosa critica a una società americana disgregata e alienante”, massimizzando e universalizzando il messaggio. Giocando, quindi, sullo stesso tavolo, e con le stesse carte, dell'esordio “Fight Club”. Stiamo proprio da quelle parti?
Sì e no. No, perché non c'è nessun intento allegorico, in questo frangente, né nessun piano di distruzione di massa, di sradicamento del male dalla radice (anzi), né di violenza fine a sé stessa. Sì, perché l'autodistruzione è l'asse portante di questo romanzo suicida – in tutti i sensi – assieme all'alienazione; meglio, alla reazione all'alienazione. Quindi, tenderei a considerare “Survivor”, al limite, una satira di una parte della società statunitense, e non della statunitense cultura tutta, e una più puntuale operazione di sonda e di scavo nella psiche del protagonista. Stavolta ha un nome “vero”: Tender Branson. Ricordate? In “Fight Club” si trattava di uno pseudonimo, Tyler Durden. Qui un nome c'è. Ma attenzione: “Le ho detto di chiamarmi Tender Branson. È quanto ho di più vicino a un nome-nome” (p. 243);
“In ogni famiglia il primogenito veniva chiamato Adama, e sarebbe stato Adam Branson a ereditare la nostra terra all'interno del distretto della comunità della Chiesa. Tutti gli altri figli dopo Adam venivano chiamati Tender. Nella famiglia Branson, questo fa di me uno degli almeno otto Tender Branson che i miei genitori hanno cresciuto per diventare lavoratori-missionari. A tutte le figlie, dalla prima all'ultima, veniva dato il nome Biddy. I tender attendono a ogni lavoro. Le biddy obbediscono agli ordini” (p. 240 e ss.).
Quindi, cautela: il nome del narratore, proprio come nell'opera prima (almeno: nell'opera prima edita) non ha nessun peso particolare; non è uno pseudonimo, ma non è fondante ed essenziale. L'autore, del resto, è uno pseudonimo vivente. Dove siamo? Siamo negli Stati Uniti, nel microcosmo di una piccola comunità – una setta – caduta in pezzi. Si chiamano “Creedish”, e il protagonista è uno dei pochi sopravvissuti al loro suicidio di massa. Al principio della storia, lui si sta suicidando: è in aereo, è rimasto solo dopo averlo dirottato, senza uccidere nessuno; sta registrando la sua voce nella scatola nera. Sta registrando la sua storia. La sua storia deriva e discende da quanto accaduto nella comunità settaria dei Creedish: l'epilogo ne è, forse, naturale conseguenza.
“Era la dottrina della Chiesa che sarebbe stato lo stesso lavoro per il resto della tua vita. La stessa solitudine. Niente sarebbe cambiato. Tutti i giorni. Questo era il successo. Il premio stava in questo. Falciare il prato. E falciare il prato. E falciare il prato. Ricominciare” (p. 190).
Automatismi e condizionamenti: non si può essere diversi dalla comunità (altro che branco: qui ci sono norme e regole, per quanto deliranti e demenziali, chiare e condivise). L'esito della propria esistenza non può deviare da quello degli altri. Non è un caso se il Programma statale per il recupero dei pochi sopravvissuti sia andato incontro a tutta una serie di fallimenti:
“I suicidi sono solo suicidi, specialmente tra questa gente. I suicidi di questi assistiti arrivano a grappoli. Azioni di massa. Uno o due possono innescarne anche una ventina. Come i lemmings. Il blocco dei fogli ufficiali cade sul pavimento, e lei dice, 'il suicidio è molto contagioso” (p. 222)
... e quindi Durkheim aveva ragione. Tender è parte di una comunità suicida, e suicida morirà, a dispetto delle prime fortune incontrate in vita: grandi fortune, commerciali ed economiche, popolarità nazionale, inatteso successo, scribacchino e qualcosa del genere... profeta (ma non delle proprie profezie) di sciagure. Tender è un esempio di morte in vita: la sua conversazione con la scatola nera sembra così naturale, così logica, così predestinata...
“Il caos non esiste. Esistono solo schemi, schemi sopra altri schemi, schemi che influenzano altri schemi. Schemi nascosti da schemi. Schemi dentro schemi. Se si guarda da vicino, la storia non fa altro che ripetere sé stessa. Quello che chiamiamo caos non è altro che uno schema che non abbiamo riconosciuto. Quello che chiamiamo caso non è altro che uno schema che non riusciamo a decifrare. E quello che non riusciamo a capire lo chiamiamo nonsense. Ciò che non possiamo leggere, lo chiamiamo borbottio. Non esiste libero arbitrio. Non ci sono variabili. 'Solo l'inevitabile esiste' – dice Fertility. 'C'è un solo futuro. Non c'è scelta'. La brutta notizia è che noi non abbiamo nessun controllo. La buona notizia è che non possiamo fare nessun errore” (pp. 117-118).
Chi è Fertility? È la profetessa che aiuterà Tender a diventare famoso. È la sorella di qualcuno che si è suicidato perché lui gli aveva detto di farlo, al telefono, quando s'era ritrovato per caso a dargli un parere (caso? Un errore sul giornale. Caso). È una ragazza incontrata al cimitero, di fronte a una tomba, e ascoltata al telefono senza che lei sapesse che con lui parlava (caso? Un errore. Caso): il telefono amico è il telefono amico del suicidio. Palahniuk accompagna le anime ferite alla morte. Palahniuk dice che niente ha senso che non sia la distruzione e l'autodistruzione. Palahniuk è furore iconoclasta e senza dio, principe della depressione: “La vita è esattamente come ha detto l'agente. Capisci che se non c'è nessuno a guardarti, tanto vale restartene a casa. A divertirti da solo. A guardare il telegiornale. È intorno al centodecimo piano che comprendi che se non sei in videocassetta, o ancora meglio, dal vivo via satellite, spiaccicato davanti al mondo intero che guarda, tu non esisti. Che sei quell'albero che cade nella foresta e di cui a nessuno gliene frega un cazzo. Puoi fare qualsiasi cosa. Se nessuno lo nota, la tua vita si azzera. Nada. Zero assoluto. Che siano vere o meno, questo è il genere di grandi verità che ti si affollano dentro. Capisci che è la nostra sfiducia nel futuro che ci rende difficile il distacco dal passato (...)” (pp. 149-150).
... la paura di adattarsi – di evolvere – inchioda al passato. Il passato del narratore – il passato prossimo – è un suicidio di massa. Alle spalle, segregazione, violenze, soprusi, arbitrii nel nome della religione, e della comunità. E intanto, i pochi sopravvissuti muoiono: suicidi, o suicidati. E questo è il secondo snodo della narrazione del suo passato, la verità sulle morti dei reduci Creedish. Mentre il narratore scopre, a suo modo, l'amore, si trova ancora ad affrontare la morte e il passato. La morte e il passato hanno il volto della sua famiglia. Nessuno vuole risolvere i problemi (p. 282), o forse nessuno può. I suicidi di massa (p. 142 per un buon indice) non sono la soluzione auspicata, ma forse non s'allontanano troppo dalla febbre distruttiva che irrora la creatività di Palahniuk.
Potrei raccontare altro, di “Survivor”. Dell'impotenza più o meno fittizia del narratore, del lavoro ingiusto della sua “compagna” (virgolette d'obbligo), della natura vicina al sosia del suo gemello maggiore, responsabile del primo “deragliamento” della sua vita post Creedish. Ma non me ne viene voglia. Rimango ancorato alla storia di una morte autoinflitta e annunciata, alla lettura dell'esistenza – non della società americana – del narratore, al condizionamento culturale e religioso d'una setta e alle sue influenze sulla sua psiche. Palahniuk non sarà mai il mio idolo, ma riconosco nella sua scrittura l'espressione della sofferenza, del male, dell'isolamento, del fallimento.
Se tutto fosse come in queste pagine appare, niente avrebbe senso. Se tutto così è, allora la risposta è l'autodistruzione. Ma questo era “Fight Club”: diciamo, una cifra autoriale.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Chuck Palahniuk (Pasco, Washington, 1962), romanziere americano di sangue ucraino. Si è laureato in giornalismo nell’Università dell’Oregon, vive a Portland.
Chuck Palahniuk, “Survivor”, Mondadori, Milano 1999. Traduzione di Michele Monina e Giovanna Capogrossi.
Prima edizione: “Survivor”, 1999.
Gianfranco Franchi, febbraio 2009.
Prima pubblicazione: Lankelot.
