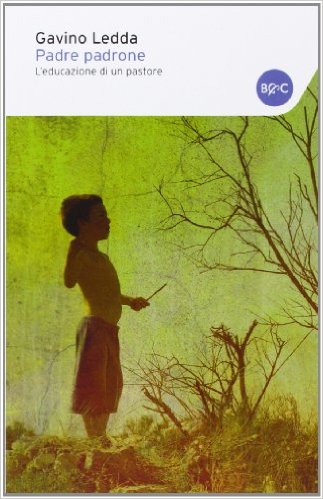 Padre padrone. L'educazione di un pastore
Padre padrone. L'educazione di un pastore
Baldini & Castoldi
2014
9788868522940

“Padre padrone” [1975] è un libro destinato a restare nella storia della nostra letteratura italiana; non soltanto per la freschezza espressiva e per la sua straordinaria vivacità linguistica, e non soltanto per la credibile e dolorosa rappresentazione delle difficoltà esistenziali e delle contraddizioni culturali dei pastori sardi. È destinato a restare perché riesce a interpretare con intelligenza, dignità e personalità il rifiuto del passaggio di consegne da padre a figlio; perché quando certe consegne sono sbagliate, a esse si deve disobbedire. Non c'è sangue e non c'è orgoglio per la tradizione che tenga. E si deve farlo perché i valori della società che Gavino Ledda (Siligo, Sassari 1938) stava ereditando non erano democratici, e non erano sempre sani. In questo romanzo, racconta la sua storia. La storia di tanti altri giovani pastori sardi. A cinque, sei anni si doveva andare a lavorare, perché così voleva la famiglia, e perché così soltanto si poteva vivere onestamente. E si andava a lavorare combattendo contro le pessime condizioni igieniche, contro le pulci, le cavallette, le locuste e le volpi, senza diritti e senza tutele, cercando oltretutto di tenere alla larga i banditi. Oltre ai banditi c'erano i banditelli, spesso “servi pastori mal nutriti, a pane e acqua e raramente formaggio, brodaglie varie e latte, che in assenza del loro padrone si industriavano a procacciarsi una pecora tra i pastori del vicinato, a rotazione, per alternare il loro cibo abituale con una bella scorpacciata di carne arrosto” (p. 45). I figli degli altri pastori, sos bighinos, i vicini, non andavano frequentati. Altrimenti le pecore sconfinavano, altrimenti si imparavano altri vizi.
Nonostante la legge fosse arrivata a farsi sentire nelle campagne, e fosse finalmente estranea a quella che Ledda chiama “ingordigia dei nobili” d'antan, a Cagliari e a Sassari, in certi contesti si restava a vivere nell'arretratezza contadina più medievale possibile. Gavino Ledda, in ogni caso, sapeva farne poesia. Così: “Quando si scatenava la natura, però, l'unico passatempo era ascoltare il discorso della pioggia. Osservare la sua danza come scendeva ritmata, giocata e frantumata dal vento. Sul tetto frondoso del bosco, scosso dal vento, che ululava sulle foglie come un lupo affamato, l'eco del temporale si spandeva. E nella solitudine, la parola della natura scatenata dominava su tutto. Io, appoggiato al fusto di un albero, riparato dalla sua cavità (in calchi tuva) o sotto la semiluna di qualche macigno (in calchi perca), riascoltavo di nuovo il vecchio silenzio, che non avevo dimenticato” (p. 105).
**
Siligo, 1944. Una mattina di febbraio, mentre la maestra si sforza di far scrivere alla lavagna il piccolo Gavino, suo padre, “sorretto dalla convinzione morale di essere il mio proprietario, con lo sguardo terrificante di un falco affamato (de unu astore famidu) dalla strada fulminò la scuola […]. La sua fierezza e la sua imponenza dominavano nell'abbigliamento pastorale: pantaloni di fustagno, giacca di velluto liscio, scarponi e berretto rigido (craccas e zizia)” (p. 8).
Suo padre è venuto a riprendersi il ragazzo. È suo: e gli serve per governare e badare alle pecore, mentre lui pensa ai campi, che danno il sostentamento al resto della famiglia. È dispiaciuto, ma non sa come fare senza di lui. Deve pensare anche ai suoi fratelli più piccoli, che hanno bisogno di mangiare. Vuole farne un pastore capace di produrre latte, formaggio e carne. “Quando sarà grande la quinta elementare la farà come fanno molti prima di arruolarsi. Lo studio è roba da ricchi: quello è per i leoni e noi non siamo che agnelli” (p. 10).
E così il piccolo Gavino, piangendo, deve accettare la realtà. La realtà è che la povertà impone questo tributo. E questo accade ancora nell'Italia moderna e democratica. E la realtà è che mentre esce dalla scuola si sente come la lepre “iscovada dae sa tana”, e in men che non si dica eccolo in groppa al somaro, vestito di tutto punto, pronto per cominciare la nuova vita. Innocente, incosciente, condannato a essere qualcosa senza avere scelta.
Comincia l'addestramento del piccolo pastore di sei anni e mezzo. Ogni tanto scappa e rimane un giorno intero a giocare con gli amichetti. Da loro impara subito una cosa; che l'unica consolazione di tutta quella solitudine è la masturbazione. Sui monti, dai monti, scappare non si può. Non si può perché padre padrone prende e lega, oppure tira cazzottoni. Come gli è stato insegnato: violenza educativa (p. 77). Fin quando non si vede il sangue. A quel punto ci si ferma.
Passa un anno. “Un solo anno di campagna mi aveva maturato di almeno dieci anni rispetto a loro. Alla scuola del babbo si imparavano cose ben più profonde di quelle aste e di quelle consonanti che loro ora sapevano a memoria. I loro giochi non me li ricordavo più e non mi attiravano. Solo il silenzio della campagna e scoprire la natura mi incuriosiva. Volevo ritornarvi al più presto” (p. 50).
Gavino, a sette anni, secondo suo padre dovrebbe già essere un pastore completo; deve sbrigare tutte le faccende dell'ovile (asportare il letame, fare fasci di legna, assiepare muretti), e mai controvoglia, a mala gana. Perché la mala gana lascia i segni in faccia (“è rimasta solo qualche traccia ancora visibile agli zigomi, e nell'animo il ricordo dolente che mi prude”, p. 80).
Crescendo, la solitudine sua e dei suoi amici si tingerà di zoofilia (“Furia di cazzo non rispetta nulla”, dice uno di loro), e di giochi violenti. Durante l'adolescenza tutto passa, sognando una vita diversa forse impossibile, aspettando che il padre padrone tenga fede alla parola data; e cioè che lasci che il ragazzo prenda almeno la licenza di quinta elementare, da privatista. Accade, e poi il destino ci mette lo zampino; la terra paterna viene distrutta da una notte di gelo, e le bestemmie non servono a niente: il futuro dei Ledda è segnato, la terra è perduta, così la rendita.
Gavino capisce che deve inventarsi qualcosa per sfuggire a tutta quella sofferenza e a quella miseria. Deve emanciparsi: deve diventare qualcosa di diverso. Lo studio potrebbe essere il sentiero per il suo riscatto. L'altro è, senza dubbio, l'emigrazione; un fenomeno ancora pienamente nel vivo negli anni Sessanta: “Sui campi si parlava spesso degli emigranti, della loro fortuna e delle loro disgrazie. E rimanevo perplesso. Certe notizie mi infilzavano il cervello e mi calavano nelle viscere come braci accese. Ma quando nei boschi e negli sterpi scatta la molla repulsiva contro l'ambiente, l'emigrazione diventa un'ossessione: ti martella continuamente il cervello” (p. 154).
Un futuro da minatore in Olanda non lo spaventa. Per fortuna il progetto fallisce, per via di noie burocratiche all'imbarco, anche. Il nostro futuro grande letterato si ritrova, così, volontario nell'Esercito. Sceglie la vita militare come viatico al riscatto sociale. L'avventura comincia male, perché il problema principale è la lingua: Gavino capisce soltanto la sua lingua, ovviamente, il sardo, e non quella italiana. Gli ufficiali decidono subito di accorparlo agli altri sardi, per evitare una malinconica rinuncia alla carriera militare della giovane recluta. Il clima cambia in fretta...
Ledda glossa: “I calabresi, i siciliani, i napoletani, a parità di cultura si esprimevano nel loro dialetto e facevano più figura di noi. La lingua nazionale era sempre più lontana dal sardo che da qualsiasi altro dialetto. Tra di noi, però, potevamo esprimerci in sardo a patto che non fossimo di servizio e che non ci fossero 'superiori' presenti […]. E questo era un fatto che costringeva noi sardi a stare sempre insieme: un branco di 'animali diversi'. La divisa ci accomunava solo per i superiori, ma nella realtà tra noi sardi e gli altri soldati c'era di mezzo la separazione della lingua” (p. 180).
**
Il resto è storia. Il pastore-soldato, animato da una determinazione magnifica e da un coraggio incredibile – da vero sardo – dà prova di umiltà, spirito di sacrificio e grande volontà, studiando a tutto spiano e conquistandosi, mano a mano, il suo futuro. L'ultimo passo sarà lo scontro col padre, di ritorno in Sardegna: il nuovo sardo e il vecchio sardo hanno una visione del mondo e della cultura radicalmente differenti – non compatibili, non più conciliabili. La violenza è fisica e verbale; il risultato, niente affatto paradossale, purtroppo, è una nuova emigrazione dall'isola. Si va a Salerno, per insegnare in un istituto privato. Incipit vita nova.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Gavino Ledda (Siligo, Sassari 1938), scrittore sardo. Ex pastore, laureato in Glottologia nel 1969, assistente di Filologia Romanza e Linguistica Sarda a Cagliari.
Gavino Ledda, “Padre padrone: l'educazione di un pastore”, Feltrinelli, Milano 1975. Collana “Franchi Narratori”, 19. Copertina di Silvio Coppola.
Traduzione cinematografica: “Padre Padrone” dei Taviani, 1977.
Approfondimento in rete: WIKI It
Gianfranco Franchi, aprile 2010.
Prima pubblicazione: Lankelot.
