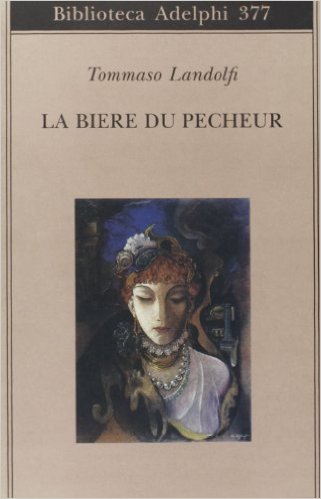 La bière du pécheur
La bière du pécheur
Rizzoli
1989
9788845914751
Che succede a Landolfi dopo “Racconto d’autunno” e “Cancroregina”? È il 1953 quando per i tipi di Vallecchi viene pubblicato “La biere du pecheur”: prepotente narrazione in prima persona – alternata a una poco credibile e presto e più volte smascherata terza, con tanto di reiterata irruzione sulla scena del narratore ad assumersi la paternità del protagonista – d’un malessere esistenziale complesso e completo. Non manca niente: si indaga sulla solitudine, sull’isolamento, sui contrastati rapporti con il gentil sesso, perfino sulla tendenza a voler descrivere tutto con eccessivo puntiglio. Landolfi si guarda dentro e cerca di trovare un senso alla sua epica passione per il gioco, sbandierando dolorose sconfitte nei casinò e ammettendo di non essere in grado di resistere alla tentazione di rischiare ancora. Trova qualcosa di sessuale, nel gioco.
Dimenticate quindi il magnifico Landolfi “romantico”, quello che lasciava andare a briglia sciolta l’immaginazione, la fantasia e le reminiscenze letterarie; fate finta che non sia mai esistito lo stravagante artista che trasfigurava il suo vissuto integrando metamorfosi, creature mannare, piattole parlanti e vermi seducenti, perché si sgretola qui, proponendo una narrativa urgente e necessaria, scrivendo per quel bisogno di consolazione che più volte da queste parti abbiamo indagato. Ridicolizzandosi per le pessime vendite dei suoi ultimi libri, aggrappandosi nell’introduzione alle parole d’un critico letterario, Carlo Bo, che l’aveva fatto sentire miracolosamente inteso e compreso, ribadendo infine più volte la sua percezione di dissociazione e estraniazione dalla realtà.
Verrebbe da dire – leggendo questo romanzo dal titolo calembour (significa sia “la bara del peccatore” che “la birra del pescatore”, divertissement autoreferenziale dell’artista fondato sul ricordo d’una triste passeggiata per Parigi, dove il diletto massimo era invertire le parole delle insegne) – che Landolfi abbia, a 45 anni, trovato la forza di mettere a fuoco “la realtà”; senza nessuna letterarietà diversa dalla lingua adottata, senza trame e senza personaggi che non siano funzionali; sono diventati persone, hanno perduto quel folle smalto che sino a questo punto li avevano caratterizzati.
Landolfi sente di vivere in uno “stato di insufficienza”: “non ho più forza né ali, e così scrivo questa specie di diario”. Scrivendo si finge lettore – è più forte di lui – e cerca di agevolarci la lettura di questo suo diario, integrando informazioni altrimenti ellittiche nei diari veri. Combatte, con aristocratico sdegno, lo “schifoso mostro detto borghesia”: ammette, al contempo, tutti i propri, tanti fallimenti. D’uno di questi in particolare – quello sentimentale – s’affanna a trovare rimedio e stabilità; se vogliamo trovare un nesso, una chiave di volta di questo romanzo, allora possiamo riconoscerla nelle tre figurette femminili che vengono descritte. Quella che appariva, sin dalle prime battute, più debole e priva di personalità è proprio la prescelta – e sembra prescelta senza una ragione apparente, al termine d’un viaggio che ha visto protagoniste altre due donne, irritate regolarmente dal distacco, dalle pretese e dall’insensibilità d’un uomo che – ripetono – non ha altro che intelligenza. L’unica ragione per cui viene chiamata, al termine del libro, futura moglie è che (verità o menzogna, l’autore se ne balocca un po’) le altre due avrebbero cercato di ucciderlo nei giorni precedenti.
“La bière du pécheur” s’apre e si chiude con un’invocazione a Dio. Non episodicamente si ritrovano richiami a quella che un tempo ci piaceva chiamare Arcadia, patria perduta e sognata, origine e meta della minoranza assoluta degli artisti – quell’eden di comprensione e armonia che tutti i letterati si trovano a invocare quando s’accorgono che l’integrazione nella società è impossibile, e che la loro permanenza in vita – in condizioni decorose – si fonda su compromessi improbabili e su elementi troppo aleatori per poter essere dominati e controllati. E intanto le nevrosi e le sofferenze crescono a dismisura, e così anche prendere un pullman per viaggiare diventa un’impresa eroica; la solitudine ammazza e il distacco dalla realtà aumenta, insostenibile, e tutto quel che rimane è provare a nominarlo e a cercarne le ragioni, le cause, il senso.
Montale – già sappiamo fosse amico e ammiratore di Landolfi – scrisse che questo libro “segue il massimo della partecipazione umana raggiunta da Landolfi nella sua arte”; probabile, e il prezzo pagato sembra essere stato carissimo. Domandarsi perché si soffre, e cercare soluzione e rimedio – trovando un’oasi di pace in una donna che neppure si ama, negli intervalli bruciando fortune al gioco, senza più nessuna fiducia nella propria scrittura. Questo è quanto.
Landolfi cerca, scrivendo, di “sbirciare il fondo di sé”: sbirciare almeno, a questo s’arriva; e intanto si guardano le donne che vogliono guarirti, con la freddezza d’un antropologo impegnato in una osservazione partecipante. Sono “oggetti necessari e non eletti”, e dovrebbero rinunciare a tutto pur di essere sue, consegnandosi come schiave ai suoi desideri e alla sua volubilità: notevole in questo senso la dichiarazione di Ginevra (p. 65 dell’edizione Longanesi, 1971). Sono “ignoranti” come tutte le “laureate in Lettere”: quanto fosse vero e sentito questo sdegnoso distacco e questa livida acredine non si riesce a percepire. Tuttavia Landolfi aiuta a capire questo suo “stato di insufficienza” quando scrive: “Dico che sempre io mi son voltolato e rivoltolato nella vita come un ammalato smanioso nel suo letto; anche mi somiglio a quelle farfalle notturne sorprese dalla luce o dall’agonia che rimangono a sbattere disperatamente le ali sui nostri pavimenti. Donde dunque, se questo è il mio stato naturale, la particolare e totale mancanza di forze, il vigile spavento?”
E così avanti, a scavare nella propria sofferenza, giudici spietati della propria inattività e della propria miseria, vagabondando per un’antica casa della piccola aristocrazia che da un momento all’altro troveranno fatiscente – come la vita dell’ultimo rampollo, il letterato, che confonde l’emozione di perdere un patrimonio alla roulette con la gioia d’amare e d’essere amato da una donna.
Landolfi non trova consolazione, ma crede in un Dio che lo attenderà al termine di tutto; nel mezzo del cammin della sua vita ha compreso che niente ha senso, e niente sconfigge la solitudine e la miseria dell’esistenza di chi vive di parole.
A latere, segnalo che qui viene nominata direttamente un’opera letteraria d’un contemporaneo che Landolfi apprezzava: Malaparte, autore de "La pelle". Sino a questo momento, nella sua narrativa, non apparivano saluti e omaggi ai contemporanei diversi dal sorriso amicale.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Tommaso Landolfi (Pico Farnese, Frosinone 1908 – Roma, 1979), scrittore, critico, saggista e traduttore italiano. Si laureò in Lingua e Letteratura Russa nel 1932, con una tesi su Anna Achmatova.
Tommaso Landolfi, “La biere du pecheur”, Longanesi, Milano, 1971.
Prima edizione: Vallecchi, Firenze, 1953.
Quindi, l’edizione esaminata, Longanesi, Milano, 1971; Rizzoli, Milano, 1989; Adelphi, Milano, 1999.
Approfondimento in rete: Centro Studi Landolfiani / Wikipedia
Gianfranco Franchi, marzo 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot.
si indaga sulla solitudine, sull’isolamento, sui contrastati rapporti con il gentil sesso, perfino sulla tendenza a voler descrivere tutto con eccessivo puntiglio
