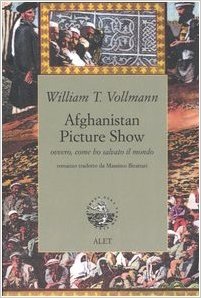 Afghanistan Picture Show
Afghanistan Picture Show
Alet
2005
9788875200114

L’idealismo di un Giovanotto non assicura la risoluzione delle guerre, non consente di salvare il mondo e non prevede il trionfo su un nemico così ostile come la dissenteria: sostiene e alimenta, piuttosto, la creazione di un documento unico e partigiano come questo romanzato e differito reportage.
William T. Vollmann, apprezzato scrittore statunitense classe 1959, pubblica nel 1992 questo “An Afghanistan Picture Show, Or, How I Saved The World”, resoconto d’una fallimentare e stupenda esperienza di vita: la sua partenza alla volta d’una terra sconvolta dalla barbarie dell’invasione socialista sovietica, il suo sostegno al popolo afgano – definito infine “estremista musulmano” dai ruus allora al potere – armato di due macchine fotografiche, tre obbiettivi e quattro rullini. In marcia, sul sentiero dell’altruismo. Per documentare e raccontare le condizioni di vita dei profughi, la solidarietà pachistana, le terrificanti violenze delle truppe occupanti comuniste; le dinamiche interne nell’allora nascente movimento dei mujaheddin, le possibilità di adattamento di un giovane yankee in quel contesto. Ambizione: sensibilizzare il Congresso e i suoi concittadini alla questione afgana, per liberare quel popolo dai tentacoli russi. L’esito non poteva essere che esclusivamente letterario… non potevano mancare sensi di colpa e fastidiosa coscienza della propria impotenza, di fronte alla (apparente e strategica) freddezza della propria patria nei confronti del dolore di quelle genti. “E il Giovanotto, con un po’ di vertigini per via della febbre, comprese all’improvviso il suo ruolo di americano: assumersi la responsabilità di qualunque cosa” (p. 84). Scrivendo.
Conserviamo quindi questo documento – rivisto, ampliato e corretto prima della pubblicazione, a diversi anni di distanza dalla trascrizione degli appunti – come fonte di informazioni a proposito di quanto avveniva quando il popolo afgano era martoriato dai sovietici: Breznev rifiutava “interferenze imperialiste” e denunciava la spedizione di reparti armati nell’Afghanistan “rivoluzionario”. Questo passo aiuta a capire la percezione afgana degli invasori russi; a parlare è un generale di brigata: “Nel sacro Corano dice: ‘Non uccidere i popoli’, ma chi è i popoli? Popoli sono popoli quando seguono i Libri Sacri. Libri Sacri è quattro: Corano, Bibbia, (indecifrabile) e Torah è i libri. Questi è popoli. Chi non piace i Libri, loro NO popolo. I ruus è selvaggi. (…)” (pp. 88-89; assieme alla denuncia degli omicidi dei bambini, delle donne; delle violenze sessuali su cadaveri di entrambi i sessi. Cfr., invece, p. 283 per apprezzare l’originalità delle mine sovietiche). Più avanti (ad es., p. 128) Vollmann ribadisce che l’ateismo sovietico era una ragione di disprezzo assoluto: l’aiuto americano era auspicato proprio per via della fratellanza tra “Popoli del Libro”.
Sin dalle prime battute del libro, che ha inizio giusto alla dogana, Vollmann si sente “incalzato”: smania per conoscere la sofferenza di un popolo e per alleviarla. Vuole adattarsi, perché: “Colui che si adatta in modo insufficiente a una società estranea è una sorta di fallimento evolutivo, condannato alla sterilità, all’isolamento, all’estinzione; colui che si adatta troppo deturpa l’io che ha avuto alla nascita. Il Giovanotto, essendo giovane, avrebbe dovuto adattarsi in maniera sostanziale; aveva una minore quantità di io precedente da negare” (p. 53). Così, vive – con qualche prevedibile difficoltà, e una serie impressionante di tenaci parassiti intestinali – come un atipico combattente afgano, senza conoscere mai altro episodio bellico che non sia una scaramuccia: non sa sparare, lui è una coscienza che sta lì per osservare e documentare. S’accompagna a figure notevoli come un discusso generale di brigata, in Pakistan per cercare nuovi aiuti: generale che si dispera per l’indifferenza americana, pretende di tornare a sparare al nemico, non vuole portarlo con sé oltre confine perché lo considera un figlio, non vuole che gli accada niente di grave.
Intanto, raccoglie e riferisce notizie interessanti: a Peshawar i mujaheddin erano suddivisi in sei fazioni, in contrasto per antagonismi tribali e ambizioni ideologiche differenti: il primo gruppo ospitava i maestri, i “mullah”, fondamentalisti; il secondo i socialdemocratici, liberal-progressisti, più vicini alle nostre sensibilità. Sappiamo bene chi ha saputo prevalere, e con quali drammatiche conseguenze, nel tempo. Una nota, a p. 128, ci aiuta a scoprire dell’altro: “Alcuni ospiti dei campi, tuttavia, facevano una distinzione tra mujahid (santo guerriero di quella che veniva percepita in primo luogo come una guerra santa) e mujahier (profugo a causa della persecuzione contro la religione)” (p. 128).
Pochi profughi erano riusciti a raggiungere gli USA o la Germania Ovest, dove avevano mantenuto un adeguato tenore di vita; gli altri erano tra Iran e Pakistan (circa tre milioni), disposti spesso a tornare indietro per combattere contro l’invasore comunista. Vollmann li descrive come generosi e solidali tra loro a dispetto delle oggettive difficoltà di vita; accenna ai giovani come a suoi simili, senza denari, educati ed estranei agli alcolici. Racconta che in ogni caso i ricchi erano assegnati agli alberghi, a Peshawar, mentre i poveri venivano assemblati in questi campi. A patire malattie, miseria, scarsità d’acqua (p. 200) e a cercare fortuna vendendo i medicinali nei bazar. Racconta di scuole senza libri, con tanti allievi di diverse età in un’unica classe.
La narrazione di “Afghanistan Picture Show” è intervallata dalla voce fuoricampo di Vollmann trentenne, consapevole del relativo fallimento della sua impresa e della sua impossibilità a incidere diversamente; il registro muta, passando da una sostanziale presa diretta, emozionale e vivida, a una più algida e matura distanza. Ne deriva un quadro di chiara vicinanza spirituale al popolo afgano – ormai difficile da decifrare per noi contemporanei, alla luce della recente invasione americana –, di netta e sprezzante distanza dalla cultura comunista: ne deriva una pacifica descrizione dell’alleanza in atto tra pachistani e statunitensi, che può rivelarsi interessante chiave di lettura per quanto recentemente accaduto in quelle terre martoriate dalle guerre. Era difficile attendersi equidistanza, considerando la nazionalità dell’autore e la sua giovinezza; meno plausibile era la possibilità di dover prendere atto della sfiorata simbiosi tra lui e i mujaheddin afghani, i futuri terroristi islamici temuti da tutte le amministrazioni americane. Al di là di qualche caratterizzazione che vellica il grottesco, l’impressione di rispetto e di considerazione nei confronti dei suoi nuovi amici è molto nitida: e decisamente interessante nell’ottica d’una lettura dei primi passi yankee per andare – pensiamo e sappiamo oggi – a sostituire con mezzi non dissimili i precedenti, irrichiesti “protettori”.
Concludo auspicando la possibilità d’una interpretazione futura soltanto letteraria di quest’opera: oggi è impossibile leggere, nella coraggiosa impresa intentata dall’allora ragazzo Vollmann, soltanto una drammatica lezione di vita; perché quelli che va descrivendo come coraggiosi guerrieri d’un popolo sofferente si sono tramutati in barbari assassini e in nemici della civiltà occidentale, nella percezione dei suoi concittadini e non solo. Stupisce quindi, nel 2007, non solo leggere la storia di questo “Rimbaud californiano”, per dirla con le parole di Tommaso Pincio: ma leggerla con la memoria intasata dai crimini di guerra di tutti gli eserciti a danno di un unico, sciagurato popolo, colpevole di abitare una terra che fa gola a tutti gli imperi. Quale che sia il loro Libro di riferimento. Gli aiuti americani sono infine arrivati: erano questi aiuti che gli afgani avevano richiesto? Intanto, gli ex alleati mujaheddin si sono rivelati primi nemici. Vollmann ne parla con diverso spirito. Almeno: non con acredine. Curioso.
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
William Tanner Vollmann (Los Angeles, California 1959), giornalista, saggista e scrittore americano.
William T. Vollmann, “Afghanistan Picture Show – ovvero, come ho salvato il mondo”, Alet, Padova 2005. Traduzione di Massimo Birattari. Risvolto di Tommaso Pincio. In appendice, una fondamentale cronologia e un elenco di fonti.
Prima edizione: “An Afghanistan Picture Show, Or, How I Saved The World”, 1992.
Approfondimento in rete: Wiki en
Gianfranco Franchi, settembre 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot.
