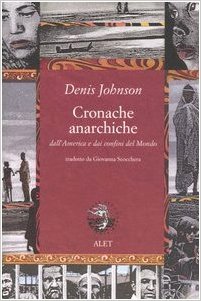 Cronache anarchiche. Dall'America e dai confini del mondo
Cronache anarchiche. Dall'America e dai confini del mondo
Alet
2005
9788875200091

“Reports from the Edges of America & Beyond” è un’appassionante raccolta di reportage curati dal giornalista, scrittore e poeta americano Denis Johnson, classe 1949, (relativamente) conosciuto dalle nostre parti per via del romanzo “Jesus’ Son” (e del film omonimo, per la regia di Alison Maclean), considerato in patria tra gli alfieri della “drug literature”.
Il valore fondamentale, mi sembra opportuno ribadirlo sin dalle prime battute, di queste “Cronache anarchiche. Dall’America e dai confini del Mondo”, è storico-documentaristico e politico: in particolare, penso ai due reportage dedicati alla Liberia, a quello dedicato all’Afghanistan, a quello dedicato alla Somalia; è invece satirico e, per un europeo, talvolta autoreferenziale quando l’autore si rivolge agli States, come ad esempio in “Il bar più basso del Montana” o nel non facilmente decifrabile “Il miliziano che è in me”, sfiorando lirismo nelle pagine sull’Alaska (“Giù di brutto per sei volte”) e ritornando con intelligenza sulla trasformazione del vagabondaggio di certe comunità americane (cfr., per le prime epifanie protonovecentesche, “Non c’è scampo” di Jack Black) in diversi frangenti (almeno in “Motociclisti nel nome di Gesù; “Vita da hippy”).
In qualche circostanza – diciamo nel caso dei reportage provenienti da Stati stranieri – si ha la felice impressione che Johnson stia appuntando note, dettagli e trame più per l’intelligence che per i lettori forti, tanto è puntuale e nitida la descrizione di determinate dinamiche e determinati meccanismi delle varie società. La narrazione non conosce particolari battute d’arresto in nessuno dei reportage pubblicati; eccezion fatta per il differente grado di appetibilità e di interesse di ogni singolo articolo. Cominciamo a segnalare il libro a quanti vanno cercando informazioni a proposito de “La guerra civile all’inferno”, dove per inferno si intende Liberia, nazione colonizzata dagli ex schiavi neri affrancati americani nel 1820, indipendente dal 1847 sino al 1980, quindi vittima di drammatici rovesci di potere, a partire dall’infame governo di Doe. Popolo, quello liberiano, che idolatra gli States, senza sapere – spiega bene Denis Johnson – che quasi nessun americano saprebbe localizzare la Liberia in un continente preciso, che nessun media ne parla e che nemmeno al Congresso la comunità nera tende a dedicare loro attenzioni che non siano distratte ed episodiche. Nel primo dei due reportage, Johnson illustra la condizione di stallo della guerra civile, accenna agli schieramenti dei due eserciti (ribelli di Taylor vs truppe del feldmaresciallo Prince Johnson, già mutilatore delle orecchie del malvagio tiranno Doe), chiarisce che le forze di peacekeeping non hanno nessuna missione in atto, a dispetto delle ripetute barbarie in corso e della loro effettiva presenza nel territorio – e sullo sfondo lascia intravedere le due barchette dei marine, guardinghe custodi (della morte).
I soldati dello sconfitto Doe sono stati massacrati e ammucchiati per le strade e per le spiagge. Gli aiuti alimentari sono insufficienti per i circa 40mila cittadini indifesi di Monrovia. Povertà e miseria vere: “La gente mangia qualsiasi cosa, e per la strada capita di vedere persone che vomitano roba non commestibile. Alcune lattine di insetticida Pestall giacciono nei canali di scolo, aperte in due, mentre il loro contenuto è stato ingurgitato da monroviani affamati e incapaci di leggere le etichette” (p. 15) – descrizione tra le più violente che ricordi, in tanti anni, e degna di drammatica meditazione. Come questa. “Le donne fanno su e giù per le strade con neonati comatosi attaccati alle mammelle vuote”
A Kabul (“Tre deserti”) i cani sembrano sentire l’arrivo dei bombardamenti, abbaiano agli aereoplani. Siamo negli anni successivi alla caduta di Najibullah, descritto come laico e come ex uomo di fiducia dei socialisti sovietici: leggiamo del suo ritiro quadriennale a Kabul terminato per mano dei talebani. Non sono i soliti, esecrabili segni del terminato orrore comunista (edifici di cemento già cadenti, macchine scassate, povertà e miseria ovunque) a stupirci; ma le prime attestazioni della condotta e della cultura dei talebani.
“Ci raffiguriamo il cittadino del nuovo secolo come un ‘minatore di informazioni’, equipaggiato per destreggiarsi tra i liberi mercati e viaggiare nel cyberspazio, ma in molta parte del mondo, l’uomo del XX secolo non ha altro che fame, un fucile e forse una religione, e non più un credo politico. ‘Abbiamo pane e preghiere’ – dicono i Talebani – non ci serve altro’.” (p. 89).
Le istituzioni – racconta il reporter – sono morte: tribunali, ambasciate, scuole e università hanno chiuso, “sopravvive molto poco, a parte le parole del profeta e i precetti del Corano” (p. 86): hanno “chiuso le altre stazioni radio e quella televisiva, tirato giù i ricevitori satellitari dai tetti, spaccato televisori e videoregistratori in strada. (…) vietato la musica, intimidito gli intellettuali e spaventato le donne tanto da ridurle all’invisibilità e al silenzio” (p. 87). E dire che paradossalmente questi esseri umani si chiamano, tra loro, “maestri e studenti”, “mullah e Talebani” (p. 84). E attribuiscono al loro Allah ogni ogni vittoria, e ogni scampata morte.
La barbarie dell’integralismo islamico non sembra difforme nell’Arabia Saudita: quelle donne senza volto, solo sguardo (p. 91: burka), in Arabia Saudita “non esistono proprio, sono piccoli vuoti completamente nascosti sotto i loro indumenti. Una donna tutta coperta di nero che percorre un vicolo chiaro e illuminato dal sole sembra un buio tremulo e assente diretto verso chissà quale insondabile, forse fatale, incarico” (p. 108). Mi sembra, in generale, che i reportage dedicati alle infelici commistioni tra Islam, leggi e costumi siano particolarmente pregevoli e necessarie per chiarirci le idee. Intanto, fischiano le prime bombe della Prima Guerra del Golfo, per Johnson una mancata Terza Guerra Mondiale, nel suo “Dispaccio” contenuto sempre in “Tre deserti”.
Cambiamo argomento. Il vagabondaggio di certe comunità americane non s’è interrotto, come era logico: Johnson racconta, ad esempio, la vicenda dei “Motociclisti nel nome di Gesù”, biker magari ex tossici o ex alcolisti che si ritrovano “ubriachi di religione” (p. 74) a celebrare nuovi battesimi e a combattere il peccato (p. 78), in cerca di sollievo, conferma o guarigione. Assieme, gli ex nomadi “Figli della Luce” (p. 99), mormoni deviati, dal Canada si ritrovano ad Agua Caliente per via d’un segno giunto tramite la tv (…). Vivono da “vergini ed eunuchi del Regno dei Cieli”, coltivano il cibo che mangiano, costruiscono le loro case e via dicendo (p. 98); in attesa della fine del mondo, per mano del fuoco.
Notevoli le pagine dedicate ai luoghi proibiti del c.d. “Stato Democratico” americano: dalle aree del Southwest, New Mexico, testimoni di varie esplosioni atomiche tra il 1950 e il 1980, in avanti (cfr. p. 96 per un elenco completo). Suggestive le (difficoltose) memorie della storia dei veri popoli americani, quelli massacrati dagli invasori spagnoli e inglesi: dei veri nativi, non degli invasori wasp, si trovano tracce a proposito della leggenda semi-orfica del fiume Colorado (p. 94) e delle rovine della misteriosa Grande Casa (p. 103) del popolo hohokam, “coloro che sono partiti”.
Altre stupende informazioni sulla Democratica Nazione che domina il mondo si ritrovano quando scopriamo il vero significato del “Telephone Privacy Act” approvato dal Congresso nel 1994: (p. 117), che prevedeva una “ristrutturazione degli impianti da parte delle compagnie telefoniche e garantiva a tal fine una sovvenzione di trecento milioni di dollari presi dai fondi federali, in modo che ogni telefono degli Stati Uniti d’America potesse essere sorvegliato dagli agenti federali nei loro uffici” (p. 117).
Registriamo, qua e là, cenni di ribellione della popolazione (p. 124, ad es., sulla “protezione” dei diritti). Mai credibili. Se non nell’allegorica ricerca dell’oro (e della libertà dallo Stato) in Alaska, o nella metaforica vicenda di quel bombarolo (imperscrutabile) nascosto in una grotta in Pennsylvania, Eric Rudolph. Ma la morale della favola Johnson ce la racconta a sangue freddo, parlando della Somalia. Multa paucis.
“Pur cominciando a vacillare e a dissolversi, l’allucinazione di massa dell’umanità resiste ancora: la visione di un pianeta di Nazioni unite, la grande illusione che lo Stato-nazione non funzioni ancora ma che lo farà un giorno, che, per portare a termine i conflitti, ci si possa fidare di quei governi che hanno ucciso ogni anno del XX secolo una media di un milione di civili che sostenevano di proteggere e di servire” (p. 185).
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Denis Johnson (Munich, Germania, 1949 - USA, 2017), giornalista, scrittore e poeta americano. Cresciuto tra Tokyo, Manila e Washington.
Denis Johnson, “Cronache anarchiche. Dall’America e dai confini del Mondo”, Alet, Padova, 2005. Traduzione di Giovanna Scocchera.
Prima edizione: “Seek: Reports from the Edges of America & Beyond”, 2001.
Gianfranco Franchi, settembre 2007.
Prima pubblicazione: Lankelot.
“Reports from the Edges of America & Beyond” è un’appassionante raccolta di reportage…
